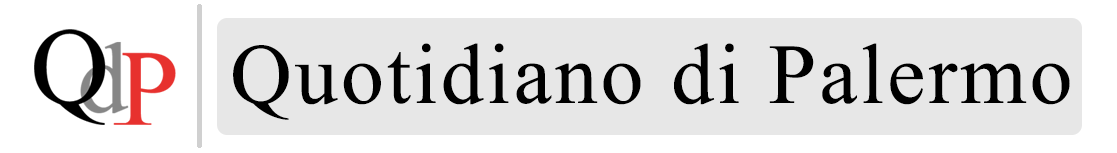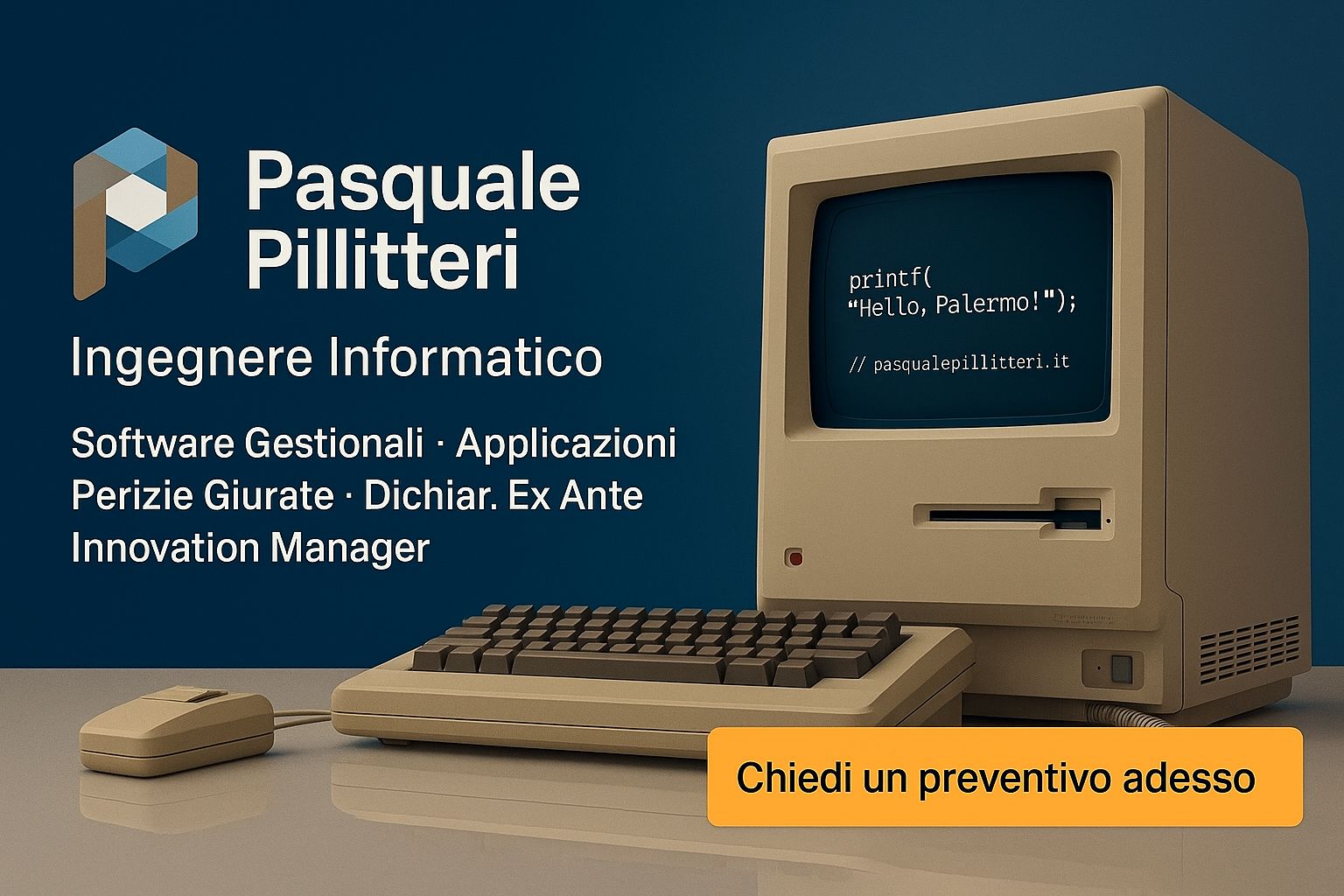Forse è una domanda che non ci poniamo abbastanza spesso, forse per disinteresse, forse per il timore di conoscerne la risposta. Eppure sarebbe importante fermarsi a riflettere: come sta, davvero, la Democrazia? Non per lamentarsi, né per puntare il dito o dire “io lo sapevo”. Ma perché la salute della politica – e della democrazia – dipende anche da noi.
Mentre l’attenzione mediatica si concentra sull’ascesa dei partiti sovranisti, resta in ombra un dato ben più inquietante: la democrazia europea è in affanno. Non solo per l’espansione delle forze estremiste, ma per una crisi più profonda, di legittimità e di partecipazione, che sta svuotando di senso le istituzioni rappresentative. E in Italia, la situazione non è affatto rassicurante.
Secondo il Global State of Democracy Report 2023, pubblicato da IDEA International, meno della metà dei Paesi del mondo può oggi definirsi una “democrazia piena”. E anche tra quelli formalmente democratici, cresce il numero di governi che indeboliscono attivamente i diritti civili, la libertà di stampa, l’indipendenza della magistratura e la partecipazione politica. L’Italia non fa eccezione a questo trend negativo.
L’Indice di Democrazia elaborato da The Economist nel 2023 colloca l’Italia tra le cosiddette “democrazie imperfette”, segnalando la scarsa fiducia nelle istituzioni, la debole affluenza elettorale e l’elevato livello di polarizzazione.
Il problema, però, non è solo chi governa: è che sempre meno persone si sentono parte del sistema democratico. Non è semplice disinteresse. È sfiducia sistemica: la sensazione che la politica sia lontana, inefficace, o addirittura ostile.
A questi elementi, nel caso della Sicilia, si aggiungono i recenti scandali legati all’Assemblea Regionale, le indagini ricorrenti che coinvolgono amministratori pubblici, e una commistione sempre più opaca con ambienti criminali.
Tutto ciò alimenta un circolo vizioso: meno partecipazione significa meno rappresentanza; meno rappresentanza significa più potere concentrato; e più potere concentrato, meno democrazia reale. Molti Paesi europei – incluso il nostro – mantengono in apparenza le strutture democratiche, ma stanno perdendo il loro contenuto sostanziale. La crescente concentrazione del potere esecutivo, il ricorso sistematico ai decreti-legge, la marginalizzazione dei parlamenti e il controllo sempre più pervasivo dell’informazione stanno normalizzando pratiche che un tempo sarebbero state definite illiberali.
In questo contesto è lecito domandarsi: una democrazia che non include, non dialoga e non risponde, è ancora una democrazia? Difendere la democrazia non significa solo garantire il diritto di voto ogni cinque anni. Significa coltivare una cultura civica, creare spazi di partecipazione quotidiana, proteggere la pluralità dell’informazione, contrastare le disuguaglianze economiche che generano disuguaglianza politica.
Ma, soprattutto, significa ricucire il legame tra istituzioni e società, superando sia la tentazione tecnocratica che il cinismo populista. Se la democrazia è in crisi, non è soltanto per l’avanzata delle destre. È anche per il vuoto lasciato da un centro e da una sinistra incapaci, negli ultimi decenni, di rinnovare linguaggi, visioni e strumenti.
Ed è proprio in quel vuoto che si insinua il rischio più grande: l’assuefazione all’autoritarismo strisciante, l’idea che la democrazia sia superflua, o – peggio – inefficace. In un’Europa che scopre la propria fragilità, e in un’Italia in cui la politica appare sempre più riservata a pochi, la sfida non è semplicemente resistere, ma rifondare.
Tornare a educare alla cittadinanza, ridare senso alla partecipazione, rimettere le persone e i territori al centro del discorso democratico. Perché la democrazia non si difende da sola.